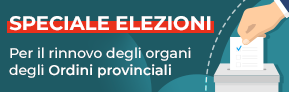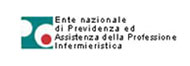La Giornata Internazionale della Gioventù, istituita dalle Nazioni Unite e celebrata il 12 agosto, è un’importante occasione per accendere i riflettori sui bisogni, i diritti e le potenzialità dei giovani in tutto il mondo. In ambito sanitario, è il momento giusto per interrogarci su come supportare al meglio i ragazzi e le ragazze nei momenti più delicati della loro crescita, non solo biologica, ma anche emotiva, sociale e sanitaria, soprattutto quando convivono con una malattia cronica come il diabete mellito di tipo 1. A livello mondiale, negli ultimi anni, questa patologia è diventata sempre più frequente tra bambini/e ed adolescenti[1],[2]. In Italia, l’incidenza varia sensibilmente tra le regioni, con tassi generalmente più elevati al Nord e un picco significativo in Sardegna[3]. Iniziative come il Registro Italiano per il Diabete di tipo 1 (RIDI) hanno contribuito in modo fondamentale a monitorare e comprendere meglio la diffusione della malattia nel nostro Paese[4]. All’aumento delle diagnosi si accompagna un altro tema cruciale: il numero crescente di giovani che affrontano il percorso di “transizione” dal sistema di cura pediatrico a quello dell’adulto. Un passaggio che non si riduce al semplice cambio del setting di cure ma che richiede lo sviluppo di autonomia, competenza e serenità nell’auto-gestione quotidiana della propria salute, dal monitoraggio della glicemia alla somministrazione dell’insulina, dall’alimentazione all’attività fisica, fino alla relazione con il nuovo team curante e la padronanza della gestione organizzativa ed amministrativa che è necessariamente correlata alla patologia diabetica[5].
Tutto ciò avviene in un periodo già complesso della vita: l’adolescenza, con i suoi cambiamenti biologici ed ormonali, emozionali e relazionali ma anche scolastici, lavorativi ed a volte anche abitativi (basti pensare agli studenti fuori sede). Se non adeguatamente preparata, questa fase può comportare una perdita di aderenza terapeutica, un’interruzione dei controlli, il peggioramento del quadro clinico, con ricadute significative sul benessere psico-fisico e soprattutto sulla sicurezza e l’incolumità del giovane adulto[6].
Per questo motivo, le principali società scientifiche, sia italiane[7] che internazionali, raccomandano un approccio strutturato, avviato precocemente (già dai 12–14 anni), multidisciplinare e centrato sul paziente. Anche il Piano Nazionale della Cronicità (2024) richiama l’importanza di garantire una transizione coordinata e continua[8].
Maria Cesarina Campagna, infermiera pediatrica, ci racconta così il suo punto di vista:
“Come infermiera pediatrica che lavora da anni accanto ai bambini e adolescenti con diabete mellito di tipo 1, ho assistito a numerosi percorsi di crescita, pieni di sfide, scoperte, timori e conquiste. Una delle fasi più complesse è senza dubbio quella della transizione dalla cura pediatrica a quella dell’adulto, un passaggio cruciale che segna una svolta nella vita del giovane con patologia cronica, ma ogni ragazzo ha tempi e bisogni diversi. Nel diabete di tipo 1 questa fase coincide spesso con un periodo già complesso dal punto di vista evolutivo: nell’adolescenza il corpo cambia, le emozioni si intensificano, il desiderio di indipendenza si fa forte, ma la gestione del diabete richiede regolarità, responsabilità e consapevolezza. Molti ragazzi vivono questo passaggio come un momento di rottura: l’ambiente protetto e familiare lascia spazio a contesti più adulti, talvolta percepiti come freddi o distanti…In questo percorso l’infermiere pediatrico ha un ruolo centrale di ascolto, accompagnamento, educazione e supporto. Non ci limitiamo a fornire informazioni, ci occupiamo di costruire competenze e fiducia. Preparare un giovane alla transizione significa valutare le sue capacità di autogestione (controllo glicemico, uso di penne, microinfusori e sensori e calcolo dei carboidrati); rinforzare le sue conoscenze ed abilità in nella vita quotidiana (gestione di iper-ipoglicemie) ma anche in situazioni eccezionali come la presenza di malattie intercorrenti, favorire e promuovere la socialità in sicurezza in caso di situazioni come viaggi o esperienze all’estero; mediare con la famiglia per promuovere una graduale autonomia evitando sia l’iperprotezione che l’abbandono. Spesso è proprio l’infermiera a fungere da ponte tra il mondo pediatrico e quello dell’adulto, a restituire continuità ed a garantire un volto familiare in mezzo al cambiamento”
Le esperienze dirette dei ragazzi e delle ragazze offre spunti preziosi di riflessione. A., L. e L. ci raccontano cosa ha significato per loro affrontare questo momento:
“La mia personale esperienza nel passaggio dall’ospedale pediatrico a quello dell’adulto è stata piuttosto positiva. Sono stata accompagnata passo per passo dai medici e dalle infermiere che mi hanno sempre colpito per empatia, gentilezza e pazienza fuori dal comune. Il mio esordio è avvenuto nel 2012 quando avevo 8 anni; le esperienze che porto con me sono segnate dalla conoscenza di persone premurose, accoglienti e molto presenti e competenti. In occasione della consueta visita trimestrale ho conosciuto quello che sarebbe stato il mio futuro medico di riferimento, mi sono state fornite le nuove indicazioni e tutto ciò’ che sarebbe cambiato; non posso negare di essermi sentita un po’ spaesata: da un ambiente a me molto familiare sono passata ad un contesto simile ma molto più grande e questo all’inizio mi ha un po’ spaventata. Oggi posso dire che sono stata ben accolta dal nuovo team poiché’ sempre pronto ad accogliere ogni mio dubbio a volte pronte a darmi risposte prima che sia io a porre le domande”.
“Non avevo capito che sarebbe stato diverso…non sono stata informata forse è per questo che sono rimasta così scioccata alla prima visita! Mi sentivo ansiosa e disorientata soprattutto perché nessuno mi aveva spiegato come sarebbe cambiato il modo di ricevere le cure”.
“La prima visita all’ospedale dell’adulto non è stata per me un’esperienza con i fiocchi purtroppo. L’ambiente, come ci si può benissimo aspettare da un ospedale per adulti, non era per niente accogliente, ma ciò che ha scioccato me e le mie amiche (fortunatamente eravamo noi solite tre amiche strette a dover effettuare la visita lo stesso giorno) è stato l’approccio del personale. Non appena siamo arrivate, infatti, ci sono state misurate pressione, altezza e peso..Il tutto condito con un linguaggio che lasciava perfettamente trasparire la nostra supposta incapacità e inesperienza nella gestione della patologia. Del tutto umiliante e svilente.. In breve, ci siamo davvero sentite non accolte e nemmeno riconosciute per le adolescenti competenti e consapevoli che eravamo”.
In questa giornata dedicata alla gioventù, rinnoviamo l’impegno come operatori sanitari nel supportare un sistema sanitario che sappia riconoscere la transizione come un processo lungo e complesso. Un sistema capace di ascoltare, formare, sostenere, promuovere la continuità tra team pediatrici e adulti, e valorizzare il contesto sociale e culturale dei giovani. Solo così possiamo garantire che ogni adolescente con patologia cronica non sia solo un paziente, ma il protagonista consapevole del proprio percorso di vita.
A cura della Commissione d’Albo Infermieri Pediatrici
Riferimenti letteratura:
[1] World Health Organization. (2024). Guidance on global monitoring for diabetes prevention and control: Framework, indicators and application. Geneva: WHO. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.[2] Armocida B, Monasta L, Sawyer SM, et al. The Burden of Type 1 and Type 2 Diabetes Among Adolescents and Young Adults in 24 Western European Countries, 1990-2019: Results From the Global Burden of Disease Study 2019. Int J Public Health. 2024;68:1606491. Published 2024 Feb 14. doi:10.3389/ijph.2023.1606491[3] Cherubini V, Chiarelli F, Altobelli E, Verrotti A, Carle F. Regional variability in the epidemiology of childhood diabetes in Italy. J Pediatr Endocrinol Metab. 1997;10(5):471-478. doi:10.1515/jpem.1997.10.5.471[4] Cherubini V. RIDI: the registry of type 1 diabetes in Italy. Diabetes Nutr Metab. 2003;16(3):203-205.[5] Graziani V, Suprani T, Di Bartolo P, Marchetti F; TransiDEA study group. From pediatric to adult care: a survey on the transition process in type 1 diabetes mellitus and the diabetes services in Italy. Acta Diabetol. 2024;61(8):1069-1076. doi:10.1007/s00592-024-02268-3[6] Graziani V, Suprani T, Di Bartolo P, et al. Esperienze di pazienti e operatori coinvolti nel processo di transizione dai servizi pediatrici ai centri dell’adulto per giovani con diabete di tipo 1 in Italia: lo studio TransiDEA (II fase) [Experiences of patients and operators involved in the transition process from pediatric services to adult centers for young people with type 1 diabetes in Italy: the TransiDEA study (2nd phase).]. Recenti Prog Med. 2025;116(5):302-309. doi:10.1701/4495.44950[7]https://www.siedp.it/files/1_SillabusDiabetetransizione2009revisionato_new.pdf[8] https://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato1737108617.pdf